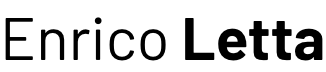Il Nord dopo la Lega – Missione Europa
Articolo di Enrico Letta pubblicato su tamtàm democratic
Colpiscono, nella stagione drammatica che l’Italia sta oggi attraversando, le tante analogie con quanto avvenne nel Paese esattamente vent’anni fa, nel biennio ’92-93. Allora come oggi, un sistema politico e istituzionale in crisi si trovò dinanzi all’imperativo di auto-riformare se stesso per reggere l’urto di trasformazioni tumultuose.
Allora come oggi, il Paese reagì con un’ondata di indignazione anti-politica agli errori commessi dal sistema medesimo tanto in termini di etica pubblica quanto sul versante della capacità amministrativa e di governo. Allora come oggi, il risentimento nei confronti dei partiti tradizionali ebbe effetti particolarmente pervasivi – e, col senno di poi, duraturi – nelle regioni produttive del Nord Italia.
Il Nord laborioso “tradito dal pentapartito”, costretto a sostenere la zavorra dell'”assistenzialismo clientelare del Mezzogiorno”, diffidente verso le forze di sinistra, spaventato al cospetto dei nuovi scenari e dalla nuova competizione economica che la fine della guerra fredda stava già dischiudendo. Di istanze di questo tenore, complice anche l’approssimazione con le quali le si tratteggiò nel dibattito pubblico, la Lega Nord si fece, com’è noto, portavoce. E sullo sfondo di Tangentopoli Umberto Bossi riuscì a emanciparsi dai ritratti caricaturali delle cronache locali per divenire, nell’arco di pochi mesi, un personaggio d’interesse internazionale: il capo di uno dei primi movimenti dichiaratamente secessionisti in una democrazia avanzata dell’Europa post-bipolare.
Di quanto questa prospettiva secessionista fosse, nel biennio ’92-93, concreta e temuta si è forse appannata la memoria nella ricognizione storica della parabola della Lega, nei decenni successivi associata prevalentemente alla deriva xenofoba, alla (presunta) grande capacità di radicamento sui territori, alle contraddizioni di un partito per anni di lotta e di governo, all’abbraccio col berlusconismo.
Eppure, è proprio in quell’orizzonte, evocato, di separazione del Nord dal resto del Paese che può individuarsi, ancora oggi a mio avviso, il cuore stesso della questione settentrionale. Una questione che è con tutta evidenza nazionale, per gli squilibri abnormi storicamente sedimentatisi con il Sud d’Italia, ma che, al contempo, ha una proiezione europea profonda e assai rilevante.
Nasce dalla vicinanza geografica e culturale con le regioni produttive più dinamiche del Vecchio Continente. Si nutre del contrasto tra i fattori di svantaggio competitivo che condizionano le performance degli attori economici e sociali nei diversi Paesi. Cresce in misura proporzionale all’evocazione delle grandi opportunità di eccellenza che il Nord, da solo, potrebbe avere se messo nelle condizioni di competere ad armi pari con gli altri.
È la carica politicamente esplosiva di questa evocazione che Bossi – paradossalmente poi trasformatosi nel leader più anti-europeista della seconda Repubblica – intuì per primo nel ’92. E lo fece proprio nel momento in cui l’Europa viveva, con Maastricht, uno degli snodi più cruciali del percorso d’integrazione comunitaria e l’Italia mostrava il fianco delle sue molteplici fragilità di sistema, con l’uscita dallo SME e lo spettro di un’esclusione, apparentemente inevitabile, dalla prima fase del processo di unificazione monetaria.
Come andò in seguito è storia recente di questo Paese e dell’Unione europea. Di certo c’è che alle pulsioni separatiste, e al rischio effettivo che esse potessero diventare qualcosa di più dello slogan di un movimento comunque marginale nel panorama politico italiano, posero un argine invalicabile solo l’azione diplomatica, il risanamento economico e lo straordinario sforzo collettivo per portare l’Italia in Europa condotto negli anni successivi da Carlo Azeglio Ciampi e da Romano Prodi.
Dopo, i leghisti si accontentarono di sventolare la ben più sbiadita bandiera del federalismo. Dopo, il furore secessionista si smorzò nel folklore delle ampolle sul Po e nelle provocazioni della Padania.
Fu con Ciampi e Prodi, dunque, che il Paese tutto intero, non solo la sua parte più ricca e competitiva, riuscì a centrare l’obiettivo dell’ingresso nell’euro. E lo fece con lo spirito di una missione condivisa, realmente nazionale e unitaria. Di quella missione siamo stati testimoni o protagonisti. Senz’altro ne siamo eredi e senz’altro dobbiamo esserne orgogliosi, perché si tratta della più qualificante esperienza di governo del centrosinistra italiano. È un’eredità tanto più onerosa e gravida di responsabilità in un momento complesso come quello attuale, nel quale alle scosse che minano la tenuta delle istituzioni e della politica si accompagna una crisi epocale, la peggiore che le generazioni contemporanee abbiano mai conosciuto.
È crisi europea e globale: di senso e di valori, di strategie e di proposte. E il populismo, nelle sue differenti e pericolosissime varianti italiane, se ne alimenta. Così come si alimenta dei nostri limiti: del ritardo – ancora – di un’autoriforma rigorosa della rappresentanza politica e dei corpi intermedi, di una deviazione endemica dalle regole nella gestione della cosa pubblica, dell’incapacità di fornire, a livello nazionale ed europeo, risposte concrete e multidimensionali a problemi complessi e spesso inediti. L’impatto, a ben vedere, è ben più corrosivo di quello del leghismo. Non solo Nord contro Sud, ma tutti contro tutti. Contro politici e governanti: parassiti, sciacalli, profittatori. Contro l’euro e l’Europa. Contro le istituzioni terze e garanti della tenuta della Repubblica. Rispetto a questa offensiva senza precedenti una grande forza come il Partito Democratico ha l’obbligo di parlare e di praticare il più possibile il linguaggio della verità e dell’unità, abbandonando ogni tentazione malsana di un ritorno alla logica del conflitto, dello scontro ideologico, degli elettorati di riferimento, degli interlocutori privilegiati.
E ha il dovere di farlo a partire dal Nord, dove la spinta populista – dopo il tracollo della Lega e l’inizio della fine di Berlusconi – pare attecchire con più rapidità e intensità. Dove il lavoro, autonomo o dipendente, è progressivamente eroso dalla crisi e le opportunità di realizzazione umana e professionale si restringono ogni giorno di più. Dove il capitalismo sta cambiando pelle e da “molecolare” si fa “di coalizione”, con le imprese, quelle che resistono, che provano a mettersi insieme per competere meglio o tentare strategie di penetrazione sui mercati esteri che nulla hanno a che vedere con le delocalizzazioni vecchia maniera. Dove lo Stato viene percepito come assente quando si tratta di erogare servizi e prestazioni, o di pagare i propri debiti, e presentissimo, invece, quanto c’è da riscuotere le tasse.
Per arginare questo populismo e fornire risposte autorevoli a una trasformazione del genere, che del resto procede a ritmi inarrestabili ovunque, è indispensabile, anche oggi, una missione alta e di prospettiva, che indichi una luce in fondo al tunnel delle difficoltà e della disperazione, che restituisca parzialmente un senso ai sacrifici affrontati e a quelli da affrontare, che abbia davvero il sapore della costruzione di futuro e dell’interesse generale. Questa missione, oggi come allora, si chiama Europa. O meglio, si chiama Stati Uniti d’Europa. Ed è di gran lunga più ambiziosa e più faticosa di quella degli anni Novanta. In discussione non ci sono, infatti, solo i tempi, variabili, dell’integrazione di questo o quel Paese, di questa o quella regione, e neanche le pur rilevanti procedure di europeizzazione di questa o quella politica pubblica.
In gioco ci sono, piuttosto, la ridefinizione dei concetti stessi di sovranità politica ed economica in Europa e la sopravvivenza di un modello di pace e di benessere, di crescita e di protezione sociale, eretto lungo tutto il Novecento ma oggi non più sostenibile così com’è.
È il futuro di questa e delle generazioni a venire che si deciderà nei prossimi mesi. E solo chiamando a raccolta le migliori energie a disposizioni del Paese e riguadagnando il suo consenso – a maggior ragione al Nord, che troppo a lungo non siamo stati in grado di capire e di guidare – potremo farci interpreti e sostenitori più convinti degli Stati Uniti d’Europa, sventando quel rischio-conflitto che tutti i populismi e tutti i separatismi, per definizione, inevitabilmente riflettono e amplificano.